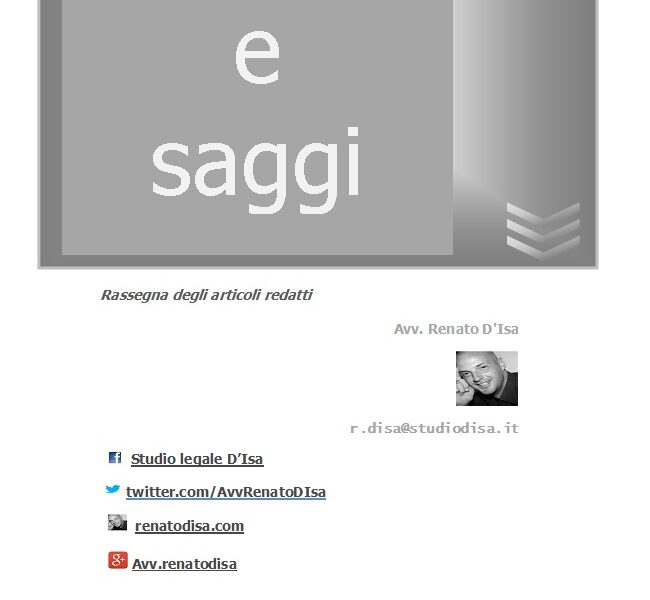A) La Donazione Rimuneratoria
art. 770 c.c. donazione rimuneratoria: è donazione anche la liberalità fatta per riconoscenza o in considerazione dei meriti del donatario o per speciale rimunerazione (ques’ultima si dice appunto speciale perché nasce dalla spontanea volontà del donante e non è fatta, invece, in considerazione o in adempimento di usi e consuetudini o tanto meno di obblighi) (c.c.797, 805).
Liberalità d’uso (donazione indiretta)
Vera e propria donazione, la cui causa è costruita, in senso soggettivo, dall’arricchimento altrui senza corrispettivo e, in senso soggettivo, dallo spirito di liberalità.
Lo spirito di liberalità non viene meno , pur se l’attribuzione è
1) o fatta per riconoscenza – sentimento di gratitudine – es. la donazione reciproca, fatta cioè, da chi, in passato beneficiato, dona ora, a sua volta al benefattore.
2) O fatta in considerazione dei meriti del donatario, verso la collettività o verso individui diversi dal donante – sentimento di ammirazione – deve però trattarsi di meriti che non hanno arrecato diretto vantaggio al donante, altrimenti si ricadrebbe nell’ipotesi successiva – es. per una scoperta scientifica – per un opera letteraria, ecc.
3) Secondo una sentenza di merito “Il prelevamento, in forza di regolare delega, del denaro depositato sul conto corrente del padre, prima della di lui morte ed in osservanza del suo desiderio di compensare la figlia per l’assistenza che gli ha prestato, deve essere considerato come una donazione indiretta remuneratoria; la somma così acquisita dalla figlia, non può formare oggetto di divisione ereditaria, ma può, però, essere ridotta al fine di integrare la quota di riserva spettante a sua sorella.”(Trib. Monza, 25/01/2001)
4) O fatta per speciale (perché non è fatta in considerazione o in adempimento di usi e consuetudini o tanto meno di obblighi) rimunerazione, per servizi resi dal donatario, anche a titolo oneroso, e particolarmente apprezzati dal donante. Questo servizio può essere sia anteriore che posteriore, purchè manchi la sinallagmaticità tra le due prestazioni – es. tipico – la donazione fatta al medico o all’ Avvocato;
In tale ultima ipotesi
a) secondo la Giurisprudenza: vi è un concorso di motivi, cosicché la donazione è configurabile ove quello liberale prevalga su quello di scambio, configurandosi altrimenti un negozio misto a donazione.
b) secondo la dottrina (Torrente): vi sarebbe un collegamento negoziale tra una datio in solutum e una liberalità, cioè tra causa solvendi e causa donandi.
Disciplina –
il donante non è tenuto verso il donatario alla garanzia per evizione entro i limiti delle prestazioni ricevute (art. 797, n. 3) e, più in generale, la donazione rimuneratoria non è mai soggetta a revoca (art. 805), né da luogo all’obbligo alimentare (art. 437)
art. 805 c.c. donazioni irrevocabili: non possono revocarsi per causa d’ingratitudine, ne per sopravvenienza di figli, le donazioni rimuneratorie quelle fatte in riguardo di un determinato matrimonio
B) L’Obbligazione Naturale:
1) La soluti retentio:
l’art. 2034 c.c. statuisce che non è ammessa la ripetizione di quanto è stato spontaneamente prestato in esecuzione di doveri morali e sciali. Salvo che la prestazione non sia stata eseguita da un incapace.
La non giuridicità di tali doveri emerge poi, oltre che dall’assenza di azione, dal fatto che la prestazione deve essere eseguita spontaneamenteladdove l’adempimento dell’obbligazione, lungi dall’essere atto spontaneo, è atto dovuto.
art. 2034 c.c. obbligazioni naturali: non è ammessa la ripetizione di quanto e stato spontaneamente prestato in esecuzione di doveri morali o sociali, salvo che la prestazione sia stata eseguita da un incapace.
2) Natura dell’adempimento:
A) negoziale: tale natura è sostenuta soprattutto in base alla considerazione che , nel caso di adempimento di obbligazione naturale ma manca la doverosità, siché si è in presenza, a seconda dei punti di vista:
1) di un contratto di attribuzioni ad effetti reali e reale (Oppo – Rescigno);
2) di un negozio unilaterale (Bianca),laddove nell’adempimento di un’obbligazione civile, l’incapacità del solvens è irrilevante trattandosi di atto dovuto (art. 1191).
Conseguenza pratica di tale teoria – è che l’atto di attribuzione sarebbe impugnabile con l’azione di annullamento per violenza, dolo, incapacità d’agire, con l’unica eccezione dell’errore.
B) non negoziale: tale teoria pone in luce il fatto che l’adempimento di per sé non costituisce un atto di autonomia negoziale, cioè di autoregolamentazione, in quanto la regola è già prefissata e discende appunto dal dovere morale o sociale che è configurato dall’ordinamento extrastatuale del tutto al di fuori ed independetemente dalla volontà del solvens, il quale in qualche modo lo subisce potendo sottrarsi all’adempimento ma non potendo porre il dovere stesso nel nulla: pur se adempiuto, infatti, esso permane inalterato ed anzi genera sanzioni sia pure sul piano dell’ordinamento sociale.
Conseguenza pratica di tale teoria – la norma, dunque, non andrebbe spiegata con la natura negoziale dell’atto ma con il principio dell’autoresponsabilità posto a tutela, tra l’altro, proprio degli incapaci.
Ciò significa però, che non si dovrà avere riguardo alla (formale) capacità d’agire ma alla (sostanziale) capacità naturale con ripetibilità, in difetto, della prescrizione, può discutersi se a prescindere del grave pregiudizio.
Del resto l’obbligazione naturale lascia libero il debitore (naturale ) di eseguire o meno la prestazione, cosicché una tale opzione non può non presupporre la capacità d’intendere e di volere cioè di autodeterminarsi all’atto in piena coscienza. In tal modo si spiega anche la rilevanza della violenza e del dolo eventualmente subiti dal solvens nonché la irrilevanza dell’errore, dovendo cedere il principio dell’autoresponsabilità di fronte alla colpa del solvens che, negligentemente, si sia ingannato.
Pagamento del debito prescritto :
A) per parte della dottrina (Bianca – Costanza), la spiegazione della norma va ritrovata al di fuori dell’obbligazione naturale se si tiene presente che la prescrizione non estingue il diritto, cosicché in caso di adempimento dovrà applicarsi la generale regola di cui all’art. 1191 che prevede l’irrilevanza dell’incapacità nell’ipotesi di adempimento di obbligazioni civili. Il pagamento, poi, non sarà revocabile trattandosi di pagamento di debito scaduto.
B) Altra parte della dottrina (Giorgianni) ritiene invece che la prescrizione operi nel senso della estinzione dell’obbligazione civile con contestuale nascita di un’obbligazione naturale e pertanto osserva che la capacità può presumersi esistente atteso che, in tal caso, l’obbligazione naturale deriva, in qualche modo, da un’obbligazione civile che a sua volta presuppone la capacità dei soggetti. Consegue a quest impostazione che l’eventuale incapacità sopravvenuta determinerebbe la repitibilità di quanto prescritto.
Nota: Dal punto di vista giuridico l’attribuzione operata da un soggetto in adempimento di un’obbligazione naturale è ritenuta dall’ordinamento giustificata e dunque non indebita, cosicché il solvens non potrà pretendere di agire con l’azione di ripetizione.
L’obbligazione naturale se non costituisce una valida causa obligandi, costituisce una valida causa solvendi, esterna senza la quale l’attribuzione patrimoniale cadrebbe.
3) attribuzione patrimoniale:
Forma – ci si chiede se sia ammissibile un trasferimento di cosa immobile a prescindere dall’osservanza della forma scritta.
In senso affermativo può sottolinearsi che la forma scritta è prevista dall’art. 1350 e cioè da una norma dettata in tema di dichiarazione di volontà mentre in questo caso si è in presenza di un comportamento esecutivo.
5) realità: la fattispecie si perfeziona dunque non verbis ma rebus.
Nota – Problema riguardo alla possibilità di novare un’obbligazione naturale con una civile: prevale nettamente la tesi negativa. Tuttavia, una volta chiarito che la sostituzione di un dovere naturale da un’obbligazione naturale con un dovere scaturente da un’obbligazione civile non dà luogo a novazione, si pone un ulteriore problema.
Ci si chiede, cioè, se l’eventuale dichiarazione con cui l’obbligato naturale assume l’impegno giuridico ad adempiere l’obbligazione naturale non sia una forma di adempimento esso stesso. Alcuni autori (Rescigno – Magazzu) sostengono la tesi positiva traendone il corollario che la dichiarazione in questione ormai effettuata divenga irretrattabile.
Nota – possibilità di effettuare una compensazione tra un’obbligazione civile con un’obbligazione naturale
Nota – non si dubita da parte della dottrina, invece, dell’ammissibilità della dazione in pagamento quale adempimento di obbligazione naturale.
– rapporti tra la Donazione Rimuneratoria e l’obbligazione naturale:
chi dona per riconoscenza o per speciale rimunerazione (ma non per i meriti del donatario) può averlo fatto perché avvertiva una sorta di coercizione, cosicché è difficile individuare il confine rispetto all’adempimento di obbligazione naturale.
Se ci si basa sull’animus il rischio è quello di dar vita ad un processo alle intenzioni.
In termini oggettivi si è invece osservato (Oppo) che l’obbligazione naturale è un dovere della morale, cosicché il giudizio sulla sua esistenza non è rimessa al singolo, il quale lo subisce come un obbligo.
In tal senso si è espressa anche la giurisprudenza unanime della Cassazione (C.14/2/’97, n.1411) la quale ha affermato che affinché si possano distinguere le due figure è necessario che il motivo dell’attribuzione patrimoniale assuma, in entrambe le figure, rilevanza giuridica: nella donazione rimuneratoria, infatti, il motivo dell’attribuzione patrimoniale deve essere correlato specificamente da un comportamento del donatario, nei cui confronti la liberalità si pone come riconoscenza; nell’ambito dell’obbligazione, invece, il motivo dell’attribuzione patrimoniale è quello di adempiere un dovere morale e sociale (vi è sempre, comunque, un animus solvendi a differenza della donazione rimuneratoria per la quale è previsto un animus donandi anche se dovuto all’osservanza di un uso o di un costume ).
“La donazione remuneratoria consiste nell’attribuzione gratuita compiuta spontaneamente e nella consapevolezza di non dover adempiere alcun obbligo giuridico, morale, sociale per compensare i servizi resi dal donatario. (Figura esclusa nella fattispecie, con riferimento alla disposizione con cui una signora aveva riconosciuto di essere debitrice di una somma pecuniaria nei confronti della nipote a titolo di gratitudine e compenso per l’assistenza, la cura e l’amministrazione ricevute per un considerevole periodo). (Cassa con rinvio, App. Venezia, 10 aprile 2003)”
Cass. civ., Sez. II, 03/03/2009, n. 5119
“Per donazione remuneratoria deve intendersi l’attribuzione gratuita compiuta spontaneamente e nella consapevolezza di non dover adempiere alcun obbligo giuridico, morale o sociale per compensare i servizi resi dal donatario; pertanto, per la validità della stessa, occorre che sia costituita con le forme di legge previste per la donazione.”
Risvolti pratici –
forma libera – per l’adempimento dell’obbligazione naturale –
forma vincolata – per la donazione.
“La disciplina del negotium mixtum cum donatione obbedisce al criterio della prevalenza, nel senso che ricorre la donazione remuneratoria (che esige la forma solenne richiesta per le donazioni tipiche) quando risulti la prevalenza dell’animus donandi, laddove si avrà invece un negozio a titolo oneroso, che non abbisogna della forma solenne, quando l’attribuzione patrimoniale venga effettuata in funzione di corrispettivo o in adempimento di una obbligazione derivante dalla legge o in osservanza di un dovere nascente dalle comuni norme morali e sociali che si riveli assorbente rispetto all’animus donandi. (Nella specie, la convivente di un soggetto sieropositivo al virus HIV aveva ricevuto da quest’ultimo una somma di danaro prima che la convivenza avesse termine: i giudici di merito, con sentenza confermata dalla S.C., qualificato l’atto come negotium mixtum cum donatione, ne avevano evidenziato la prevalenza dell’aspetto risarcitorio su quello di liberalità, rigettando la richiesta di restituzione del ricorrente).”
Cass. civ., Sez. I, 29/05/1999, n. 5265
“Non sussistono gli estremi per riconoscere l’esistenza di una donazione indiretta o di una donazione remuneratoria quando difettano sia gli elementi formali della donazione sia la prova dell’animus donandi. Inoltre, come nel caso all’attenzione, non può ipotizzarsi donazione remuneratoria laddove non venga né fornita né dedotta prova alcuna della particolare attività di accudimento asserita.”
Trib. Genova, Sez. I, 02/08/2006
“L’attribuzione patrimoniale effettuata in favore del convivente “more uxorio”, a titolo di ristoro per il sacrificio della sua aspirazione ad un’esistenza autonoma ed indipendente, nonchè al fine di assicurargli un’autosufficienza economica per il tempo successivo alla cessazione del rapporto, si configura come adempimento di un’obbligazione naturale piuttosto che come donazione remuneratoria, purchè la prestazione risulti adeguata alle circostanze e proporzionata all’entità del patrimonio ed alle condizioni sociali del “solvens”.”
3) Le Liberalità d’uso:
La liberalità d’uso solitamente costituisce un’elargizione che solitamente viene fatta in occasione di particolari servizi resi o in conformità agli usi vigenti in un determinato luogo.
La causa di siffatta attribuzione non appare prime facie diversa da quella del negozio di liberalità donativa, comportando l’impoverimento del donante e arricchimento del donatario.
Si osserva (C. 5/4/’75, n.1218) come il particolare motivo dell’attribuzione, rappresentato dall’intento di compensare un soggetto per i servizi da costui ricevuti, nel rispetto di un uso diffusosi in una determinata località e in un determinato periodo di tempo, finisca con il mutare la causa della liberalità, non più spontanea ma eseguita in osservanza del vigente costume.
In altri termini: chi dona in occasione di una festività non lo fa del tutto spontaneamente, ma magri contro voglia perché costretto dalla conformità agli usi.
Secondo la recente Cassazione “la qualificazione giuridica di un’elargizione come liberalità effettuata in conformità agli usi ex art. 770, secondo comma, cod. civ., deve risultare non solo dal rapporto con la potenzialità economica del donante ma anche in relazione alle condizioni sociali in cui si svolge la sua vita di relazione, oltre che dal concreto accertamento dell'”animus solvendi” consistente nell’equivalenza economica tra servizi resi e liberalità ed, infine, dall’effettiva corrispondenza agli usi, intesi come costumi sociali e familiari.(Nella specie il giudice di merito aveva qualificato secondo gli usi l’elargizione fatta dal donante prima di morire alla convivente “more uxorio” consistente in un giroconto per acquisto titoli per 64 milioni di lire e quadri d’autore. La Corte ha cassato con rinvio perché non era stata accertata e motivata l’esistenza delle condizioni qualificanti la liberalità d’uso). (Cassa con rinvio, App. Bologna, 14 Ottobre 2003)”
Cass. civ., Sez. II, 18/06/2008, n. 16550
Natura giuridica –
contratto per le stesse ragioni addotte con riferimento all’adempimento dell’obbligazione naturale –
Sembra preferibile ritenere che la liberalità d’uso non si distingue dalla donazione per l’elemento causale, perché in entrambe le figure vi è arricchimento e impoverimento ma si distingue, oltre che per il motivo (dovere morale), per l’elemento soggettivo.
Forma –
Non è necessaria quella solenne
Disciplina –
a differenza delle donazioni indirette non costituiscono donazione (art.770, 2°comma) per cui non sono soggette nè a Revocazione nè a Riduzione.
Una particolare liberalità d’uso è quella prevista dall’art.80 c.c. (doni fatti a causa della promessa di matrimonio: anelli di fidanzamento, somme di danaro, etc), essi quando il fidanzamento viene sciolto debbono essere restituiti (la relativa azione è solo civile, non potendosi parlare di appropriazione indebita in quanto il donatario ne ha acquisito la proprietà con la traditio).
Mentre secondo la Cassazione “Un’elargizione di gioielli fatta allo scopo di consentire la prosecuzione di una convivenza, non è assimilabile alla liberalità d’uso, caratterizzata dal fatto che colui che la compie intende osservare un uso, cioè adeguarsi ad un costume vigente nell’ambiente sociale d’appartenenza, costume che determina anche la misura dell’elargizione in funzione della diversa posizione sociale delle parti, delle diverse occasioni ed in proporzione delle loro condizioni economiche, nel senso che comunque la donazione non debba comportare un depauperamento apprezzabile nel patrimonio di chi la compie. (Cass. civ., Sez. II, 24/11/1998, n. 11894)”
La differenza inoltre tra le due figure (liberalità e donazione rimuneratoria) verte anche sui motivi: per la liberalità d’uso il motivo ispiratore è il servizio reso o comunque la conformità agli usi.